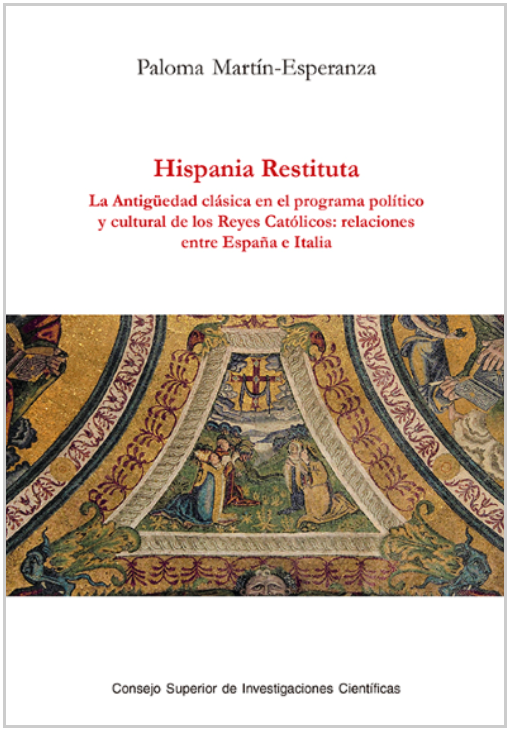Paloma Martín-Esperanza, Hispania Restituta. La Antigüedad clásica en el programa político y cultural de los Reyes Católicos: relaciones entre España e Italia, Madrid, C.S.I.C., 2023, 658 pp.
Il libro di Paloma Martín-Esperanza viene alla luce come undicesima pubblicazione della Serie Histórica, la prestigiosa collana edita dalla Escuela Española de Historia y Arqueología di Roma, e si presenta agli studiosi e ai cultori della materia in una veste quanto mai attuale ed esauriente. Senza peccare di eccessive lodi, infatti, il lavoro svolto dall’autrice può essere apprezzato già da un primo sguardo all’indice che appare lo specchio di un lavoro approfondito ed eccellente.
Paloma Martín-Esperanza è una giovane studiosa. Storica e giornalista, attualmente è ricercatrice e docente di Arte Antica presso l’Università Autonoma di Madrid, dove ha conseguito il titolo dottorale in Studi del Mondo Antico e per il quale è stata insignita del Premio Straordinario di Dottorato. Nella sua ancor breve carriera ha realizzato soggiorni di ricerca presso diverse accademie europee: le Università romane di Tor Vergata e La Sapienza, il Warburg Institute di Londra, l’Università di Amburgo in Germania. La sua formazione l’ha vista approcciarsi anche a biblioteche e archivi di prestigiose istituzioni quali l’Escuela Española de Historia y Arqueología (EEHAR – CSIC) di Roma o la Real Academia de la Historia di Madrid.
Il proposito dell’autrice è quello di presentare uno studio accurato sulla riscoperta, la valorizzazione e l’uso dell’Antichità classica durante il regno di Ferdinando II d’Aragona (1452-1516) e Isabella I di Castiglia (1451-1504), periodo che fu di transizione tra Medioevo e Modernità e che ha coinciso con l’arrivo nella Penisola Iberica del movimento rinascimentale italiano. L’indagine, inserita nel vasto contesto degli studi sulla ‘ricezione’ dell’Antichità, affronta e analizza la conoscenza della storia antica, attraverso i suoi protagonisti, i suoi testi e le sue rappresentazioni, nel modo in cui essa fu coltivata dagli intellettuali che gravitarono presso la corte dei Re Cattolici, e fu poi applicata nella politica castigliano-aragonese alla fine del XV secolo. Questo periodo, d’altra parte, è stato definito dalla storiografia come l’inizio del cambiamento della visione verso l’Antico, coincidente anche con una lunga e prolifica riflessione politica, la quale, illuminata dalle fonti classiche, ha portato successivamente a una ridefinizione dei concetti di regalità e di potere monarchico, nonché della stessa identità ispanica.
Correva l’anno 1492 quando Muhammad XII, meglio conosciuto come Boabdil, ultimo sultano di Granada, consegnava ai due monarchi di Spagna le chiavi del suo piccolo regno e contemporaneamente Bernardino López de Carvajal, cardinale e ambasciatore a Roma dei Re Cattolici, pronunciava davanti alla curia pontificia le solenni parole: «la virtù e la gloria della Hispania sono state restaurate».
Finalmente, l’antica provincia di Spagna, fondata dai Romani nella Penisola Iberica, culla di uomini illustri e fonte di ricchezza, era tornata al suo atavico splendore grazie all’opera di Ferdinando e Isabella, i quali avevano perseguito con fermezza e costanza il loro progetto di unificazione dei regni. Si trattava, sostanzialmente, non solo di recuperare il legame storico tra la Spagna e Roma per elogiare il prestigio e la leadership dei Re Cattolici rispetto agli altri monarchi d’Europa, ma di esaltare allo stesso tempo il loro complesso programma politico.
In quest’opera l’autrice, nel percorrere gli studi che affrontano le tematiche inerenti la ‘ricezione’ dell’Antichità classica, e quindi il suo accoglimento e la sua piena diffusione nella Penisola Iberica, si apre a un’approfondita analisi del rilevante trasferimento culturale che alla fine del XV secolo si sviluppò lungo la direttrice Italia-Spagna, consentendo l’introduzione dell’umanesimo monarchico nella Castiglia e in Aragona.
Fu un’epoca in cui, attraverso la storiografia dell’archeologia e la letteratura politica, fiorì un nuovo interesse per il passato classico che diede origine a sua volta a due grandi fenomeni interconnessi: l’inizio della cultura antiquaria con il conseguente incremento della scienza archeologica e l’uso della cultura classica nella sfera politica. Fu così che un folto gruppo di intellettuali al servizio di Ferdinando e Isabella ebbe il merito di sviluppare, alle porte del Rinascimento spagnolo, due argomenti cruciali che furono alla base dell’ideologia monarchica ispanica dei secoli successivi: l’unità iberica e la dottrina imperiale.
I Re Cattolici, in quanto figli di Ercole e Cesari di un nuovo Impero, avevano favorito e portato a compimento l’unificazione della Penisola Iberica; una crescita straordinaria per la quale il noto umanista Antonio de Nebrija fu indotto a scrivere nelle pagine della sua cronaca sul Regno di Spagna l’eclatante espressione: «Hispania tota sibi Restituta est».
In conclusione, sono molte le ragioni che inducono a elogiare il lavoro di Paloma Martín-Esperanza.
La prima è che l’autrice presenta in questo libro qualcosa che ancora ci mancava, ovvero una visione globale del ruolo del mondo greco-romano in uno dei periodi più salienti della storia di Spagna al principio dell’Età moderna. In pochi luoghi d’Europa, infatti, il cambiamento che caratterizzò l’introduzione dello Stato moderno si unì a un altro mutamento, altrettanto reale e immanente, come quello rappresentato dall’unione dei grandi regni iberici.
La seconda ragione è che il volume è una prova di quanto gli studi sulla tradizione classica abbiano acquisito in Spagna un livello elevato di maturità. Non vi è miglior modo di capire i progressi di una disciplina se non nel constatare i risultati raggiunti grazie a pubblicazioni di questa profondità. Il volume è frutto di uno studio scrupoloso, di una scelta attenta e razionale della documentazione e della bibliografia, ampie e perfettamente equilibrate, che l’autrice ha saputo far proprie nel corso di tutta la sua opera, attraverso un’analisi e un’applicazione accurate.
Alessandra Cioppi
(Notiziario n. 118, febbraio-marzo 2024, pp. 10-11)